
E’ difficile dire – se non chiedendoglielo – se una persona è felice, triste, divertita, imbarazzata, disgustata, invidiosa, sorpresa, sospettosa, sicura o innamorata.
Di sicuro voi sapete quale emozione state vivendo ma è molto più difficile capire le emozioni negli altri.
La teoria del juke box prende il nome dagli esperimenti condotti nel 1962 da due noti ricercatori, Schachter e Singer, i quali indussero speciali emozioni in persone che si erano volontariamente sottoposte all’esperimento. La risposta di questi dipendeva da ciò che gli sperimentatori volevano fargli credere.
In pratica i ricercatori iniettarono adrenalina in alcuni soggetti dicendo loro che si trattava di una nuova vitamina e che l’esperimento consisteva di rilevarne gli effetti sulla percezione visiva.
Tutto falso!

- Furono fatti accomodare in una stanza in attesa che fossero chiamati. In effetti il vero esperimento avveniva mentre loro aspettavano.
Nella stanza entrava una persona che incominciava a comportarsi in modo bizzarro. Costruiva con i fogli delle riviste degli aeroplanini che faceva poi volare oppure giocava a pallacanestro con carta appallottolata o lanciava urli imitando tarzan, oppure si mostrava arrabbiata e provocava il malcapitato. Iniettando adrenalina possiamo provocare alterazioni dello stato emotivo come l’aumento del battito cardiaco, della pressione, eccitazione generalizzata ma senza la presenza di un motivo apparente.
Ad altri soggetti sperimentali che ricevettero l’iniezione furono date informazioni veritiere: che l’iniezione avrebbe prodotto un lieve tremore alle mani, un aumento del battito cardiaco e una sensazione di calore in faccia. - A un terzo gruppo furono date informazioni sbagliate sugli effetti del farmaco: torpore nei piedi, una sensazione di prurito e un leggero mal di testa. Un quarto gruppo non ricevette alcuna iniezione e non fu data alcuna informazione.
Gran parte di coloro che avevano avuto l’informazione corretta non accettarono l’invito a giocare o la provocazione, cioè non si fecero influenzare dall’attore, mentre tutti gli altri risposero in vario modo. Essi erano consapevoli degli effetti del farmaco e così potevano resistere alle provocazioni del complice dello sperimentatore.
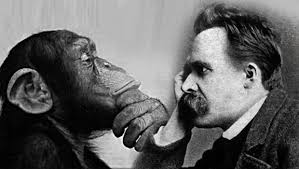
Adesso comprendiamo meglio perchè la teoria di Schachter e Singer fu chiamate teoria del juke box, poichè la stessa droga data a gruppi di soggetti li rese felici, li rese arrabbiati, o non ebbe alcun effetto sulle loro emozioni e ciò in funzione della comprensione della situazione da parte del soggetto.
In pratica, quando le persone sanno quali reazioni attendersi, interpretano correttamente i loro cambiamenti fisiologici come risultanti dall’iniezione; quando non hanno una spiegazione per ciò che sentono, interpretano questi effetti nei termini della situazione.
L’iniezione della droga – come la moneta che si mette nel juke box – mette le cose in azione, fornisce l’energia, ma la melodia suonata dipende da quale bottone si è premuto.
La conclusione che possiamo attribuire alla teoria del juke box è molto importante per il punto di vista cognitivo.
Essa spiega che allorquando uno di noi riceve le informazioni giuste dello stimolo anche doloroso a cui viene sottoposto, reagisce in modo più appropriato e si sente più in grado di affrontare situazioni anche difficili. Perciò, con i figli piccoli bisogna avvertirli quando devono fare la puntura. “Ti farà un po’ male ma tu metticela tutta e resisti”.

Viceversa sopraggiunge una risposta generale e approssimativa che porta alla confusione, alla paura incolta e animalesca.
Nelle vicende che descrivo nel mio libro “Caso e destino” i risultati di questa teoria costituiscono un altro tassello nella costruzione della consapevolezza del nostro agire. Il mio scopo definitivo è convincervi che è possibile procrastinare un esito o resistere ad una emozione disgregante e pericolosa come può essere lo stimolo aggressivo o quello sessuale. Ma la condizione più importante da sostenere è quella che fa di ogni individuo un uomo consapevole sia nella valutazione delle nostre emozioni che negli altri.
Anche per chi soffre in ospedale: dare tutte le informazioni sulla malattia grave o lieve di cui si è affetti, con l’esortazione a combattere assieme alla medicina, ci da tutto il coraggio per andare avanti poichè dentro di noi ci sono tutte le risorse per riuscirvi.


